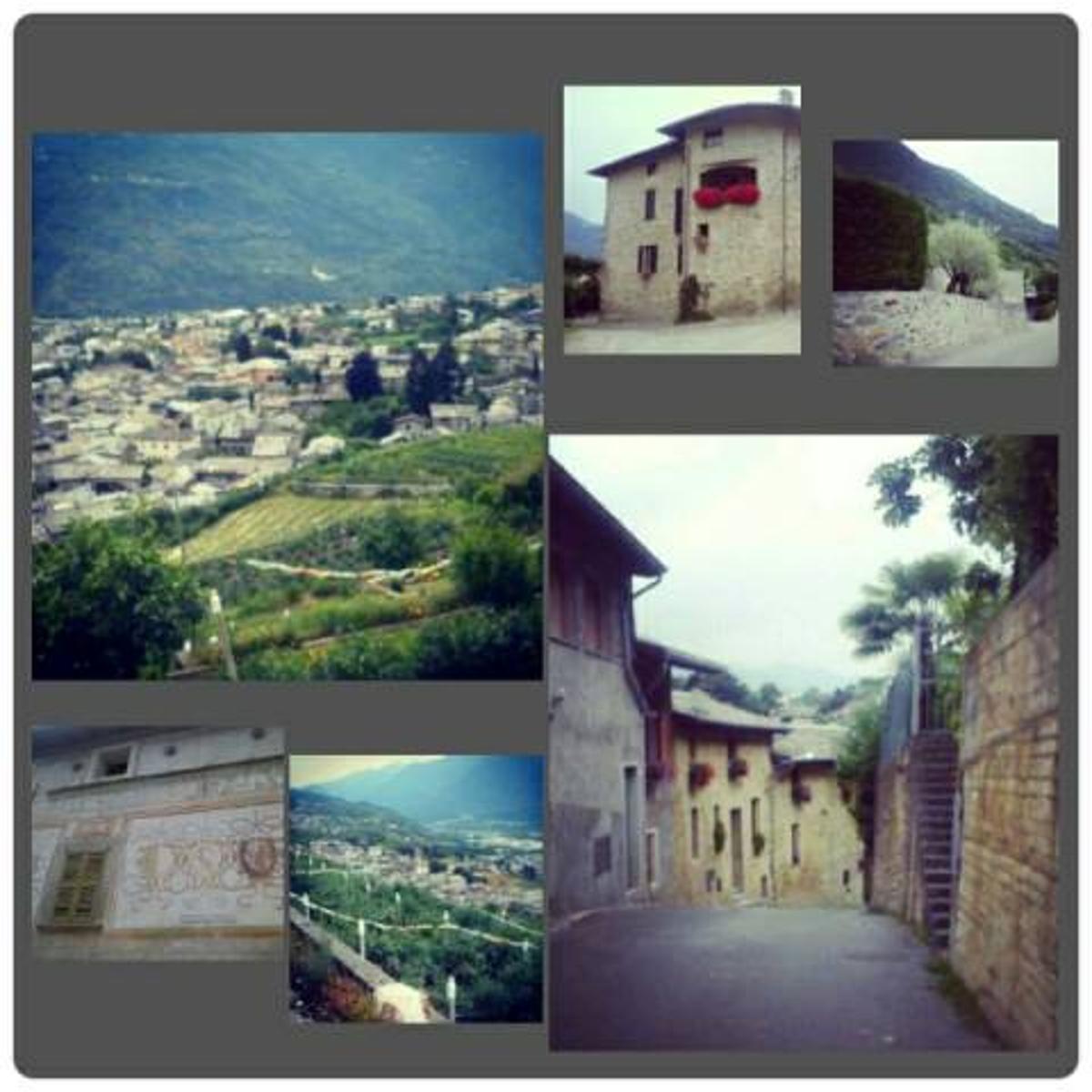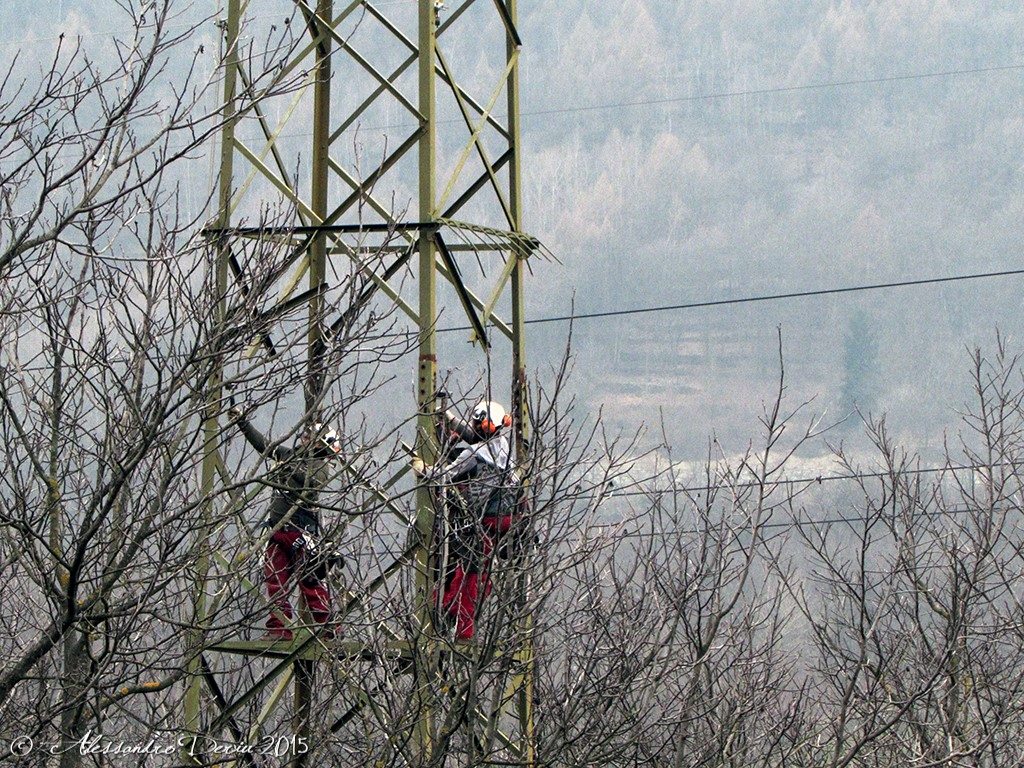Un territorio da attraversare
Nella seconda metà del XIX secolo, le vallate alpine presentavano notevoli difficoltà di accesso: le strade erano spesso sterrate, i passi alpini rimanevano chiusi nei mesi invernali e la motorizzazione era ancora molto limitata. In questo contesto, il trasporto di persone e merci si affidava alle diligenze — vetture trainate da cavalli — che costituivano l’ossatura delle comunicazioni tra i borghi e le terre alte.
In Valtellina, queste diligenze svolgevano un ruolo fondamentale nel collegare le comunità sparse nelle valli laterali e nei passi. Il servizio era relativamente “organizzato” per quei tempi: tra Sondrio e Colico erano attive tre corse giornaliere; tra Sondrio e Tirano due corse; tra Tirano e Bormio almeno una, con possibilità di più corse nei periodi di maggior afflusso. Inoltre vi erano collegamenti stagionali con Edolo via Passo dell’Aprica, e con la Val Venosta attraverso il Passo dello Stelvio, quando le condizioni meteo lo permettevano.
Le diligenze non erano soltanto un mezzo di trasporto, ma anche uno strumento di coesione sociale e di sviluppo: permettevano spostamenti per affari, commercio, pellegrinaggi, turismo nascente. E proprio nel contesto turistico di fine Ottocento e inizio Novecento, si inserisce la vicenda della ditta Perego, che avrebbe giocato un ruolo di rilievo nella “transizione” dal mondo dei cavalli a quello dei motori.
Le diligenze valtellinesi: regime, tariffe, organizzazione
Le corse e i collegamenti
Le diligenze percorrevano tutta la valle con regolarità — non in modo casuale, ma con corse programmate. Per esempio:
-
Sondrio – Colico: tre corse quotidiane
-
Sondrio – Tirano: due corse
-
Tirano – Bormio: almeno una corsa al giorno, con possibilità di corse aggiuntive in periodi di maggiore domanda
Oltre a queste “arterie centrali”, venivano garantiti collegamenti con zone alpine più isolate:
-
Edolo, tramite il Passo dell’Aprica
-
Val Venosta, attraverso il Passo dello Stelvio — ma solo quando il passo era sgombro dalla neve
Va notato che questi collegamenti “di montagna” erano soggetti alle variabili climatiche: nevicate, condizioni dell’asfalto (o meglio del fondo stradale), frane, manutenzione limitata.
Una testimonianza utile è data da una guida ottocentesca relativa a Tirano: “le messaggerie valtellinesi compiono giornalmente due corse da Tirano a Bormio (ore due e mezzo) … e una da Tirano a Morbegno e Colico”.
Tariffe e noleggi privati
Nel 1880, la tariffa per noleggiare carrozze (cioè non le corse di linea, ma vetture private con conducente) era fissata come segue:
-
8 lire per carrozze trainate da un solo cavallo
-
20 lire per carrozze trainate da due cavalli
Questo costo indicava non solo il trasporto, ma anche l’“onere del cavallo”, la manutenzione e il rischio — non certo un servizio economico. Chi poteva permetterselo, poteva così “virare” su servizio speciale con carrozza privata invece di attendere la diligenza.
Spesso nei centri più grandi, presso le stazioni postali o centri di snodo, erano disponibili vetture (e relativi vetturini) “a chiamata”, anche per destinazioni minori. Così le “messaggerie” potevano integrare le corse di linea per zone meno servite.
Il passaggio all’automobile: il cambiamento epocale
Con l’avvento dell’automobile e poi delle corriere (autobus), le diligenze furono progressivamente sostituite. Il cambiamento fu rapido, rispetto ai tempi di altre innovazioni alpine, grazie anche alle esigenze turistiche e all’evoluzione delle strade.
Le prime auto e corriere in Valtellina
Inizialmente, le automobili utilizzate per il trasporto passeggeri erano modelli relativamente piccoli, in grado di trasportare da 6 a 10 persone. Questo tipo di veicolo era già un salto significativo rispetto alla carrozza: maggiore velocità, capacità, minore fatica per i cavalli, possibilità di coprire distanze maggiori in tempi più brevi.
Nel contesto delle “gite organizzate” (visitatori che arrivavano in Valtellina per turismo), era comune utilizzare il treno fino a Tirano (dato che Tirano era un nodo ferroviario) e quindi proseguire con le automobili (corriere) verso le località alpine — modalità che sfruttava la complementarietà tra ferrovia e trasporto su strada.
La ditta Perego: da carrozze a corriere
Una figura centrale in questa transizione è la ditta Automobilistica Perego, con base a Tirano. Il suo fondatore, Carlo Perego, nel 1914 ottenne una concessione provinciale per il trasporto persone, dando il via a una attività che avrebbe acquisito grande importanza.
Carlo Perego proveniva da un’attività con cavalli e carrozze; osservando il progresso dei mezzi motorizzati, decise di acquistare diligenze, cavalli e anche servizi postali esistenti (ad es. da imprese come Buzzi di Sondrio) per avviare il trasporto automobilistico.
Così, la ditta Perego incarnò la “nuova era” dei trasporti: non più vetture trainate da cavalli, ma motori, corriere, autobus. Questo consentì di superare limiti geografici e temporali che le diligenze non potevano oltrepassare facilmente.
Impatti sociali, economici e infrastrutturali
La transizione da diligenze a corriere non fu solo tecnica, ma cambiò profondamente la vita nelle valli.
Migliore mobilità e sviluppo del turismo
Con tempi di viaggio ridotti e corse più frequenti, anche i borghi più remoti furono “riavvicinati”. Il turismo alpino, che già verso la fine del XIX secolo stava muovendo i primi passi, poté fare maggiore uso dei trasporti motorizzati per portare visitatori a Bormio, Stelvio e altri centri d’alta quota.
Le “gite” con gruppi numerosi seguirono una strategia: uso del treno fino a Tirano e poi proseguimento in corriera — ciò minimizzava i disagi e sfruttava le infrastrutture ferroviarie esistenti. In poche parole, si creò una sorta di sistema intermodale: ferrovia + strada.
Pressione sull’infrastruttura stradale
L’uso delle auto e delle corriere impose miglioramenti delle strade: ripavimentazioni, ampliamenti, manutenzioni più frequenti. I passi alpini dovevano essere resi più percorribili, con spalatori, segnaletica, opere di consolidamento contro frane.
Dove una diligenza poteva impiegare molto tempo o evitare tratti difficili, le corriere necessitavano di standard migliori per garantire regolarità anche in stagioni intermedie.
Declino e memoria delle diligenze
Le diligenze, con il tempo, scomparvero dal panorama dei trasporti attivi, restando solo nella memoria collettiva o nei musei. A Bormio, il museo civico conserva una diligenza ottocentesca che collegava Bormio al Tirolo tramite il Passo dello Stelvio.
La loro funzione — trasporto su tratte alpine complesse — divenne insostenibile rispetto alle esigenze moderne: velocità, costo, manutenzione. Il motore vinse, ma le diligenze restano simbolo di un’epoca eroica e lenta, legata al ritmo delle gesta e del paesaggio alpino.
Un’evoluzione necessaria
L’evoluzione del trasporto in Valtellina, da diligenze ottocentesche a corriere del XX secolo, è un capitolo affascinante che intreccia geografia, innovazione tecnica, esigenze turistiche, economia locale e visione imprenditoriale. Le corse multiple tra Sondrio, Colico, Tirano e Bormio testimoniano che la valle non era isolata, ma ben collegata — almeno relativamente — già in epoca preindustriale. L’avvento dell’automobile rese i viaggi più rapidi e comodi, aprendo la Valtellina a un turismo su scala più ampia e stimolando miglioramenti infrastrutturali.