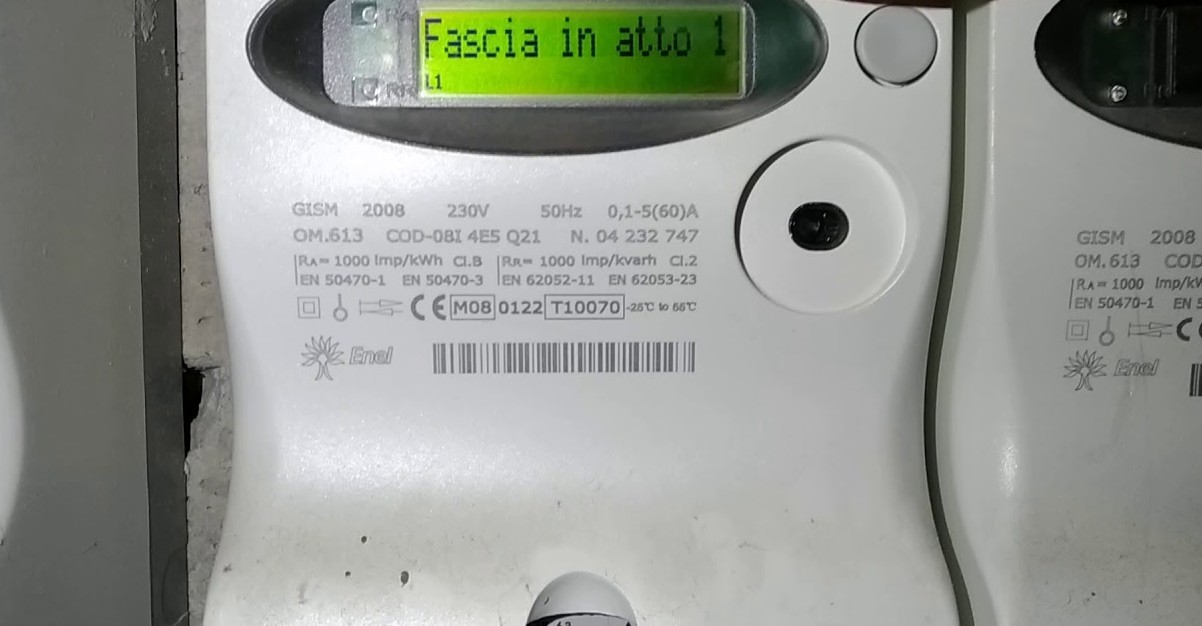Il colore rosso delle case cantoniere: un simbolo di visibilità e identità
Le case cantoniere, con il loro inconfondibile colore rosso pompeiano, sono da sempre una presenza familiare lungo le strade statali italiane. Ma perché proprio questo colore? La scelta non è casuale: il rosso fu adottato per garantire massima visibilità anche in condizioni atmosferiche avverse, rendendo queste strutture facilmente riconoscibili da lontano. Questo colore divenne un vero e proprio simbolo istituzionale, identificando le case cantoniere come presidi dello Stato sul territorio. La decisione di uniformare il colore delle case cantoniere risale al 1934, quando si volle creare un’immagine coerente e riconoscibile per queste strutture fondamentali per la manutenzione stradale.
Origine e funzione delle case cantoniere lungo le strade italiane
Le case cantoniere devono il loro nome ai cantonieri, gli operai incaricati della manutenzione ordinaria delle strade. Già nella prima metà dell’Ottocento, l’ingegnere Giovanni Antonio Carbonazzi propose in Sardegna la creazione di un corpo stabile di manutentori con alloggio nei pressi delle tratte stradali. La funzione abitativa e operativa di queste case fu ufficializzata dopo l’Unità d’Italia: un regio decreto del 1874 stabiliva la presenza quotidiana dei cantonieri lungo il tratto assegnato, anche in caso di maltempo. Per garantire questa presenza costante, vennero costruite abitazioni di servizio ogni 3-4 chilometri.
Un presidio dello Stato sul territorio
Con la fondazione dell’Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.) nel 1928, la rete delle case cantoniere divenne ancora più capillare. Al loro interno erano previsti spazi per depositi di attrezzi, stalle per animali e camere da offrire in emergenza ai viandanti. Durante il ventennio fascista, le case cantoniere vennero ulteriormente diffuse e censite. Nel 1938 se ne contavano oltre 1.300, con più di 2.300 alloggi. Il colore rosso, deciso per uniformare l’immagine pubblica, divenne una sorta di marchio visivo nazionale.
La trasformazione delle case cantoniere dopo la fine del Novecento
Dopo la Seconda guerra mondiale, la gestione delle strade passò all’Anas (istituita nel 1946), che mantenne le case cantoniere come alloggi di servizio. A partire dagli anni Ottanta, però, il sistema della manutenzione fu centralizzato, riducendo il numero di cantonieri residenti. Molti edifici furono così dismessi o lasciati in stato di abbandono. Solo una parte continua oggi a essere utilizzata per fini operativi, come magazzini o sedi logistiche, mentre altre sono state date in concessione a enti locali, associazioni o trasformate in attività ricettive.
Progetti di recupero: tra ostacoli burocratici e valorizzazione culturale
Nel 2015 è stato avviato un progetto congiunto tra MiBACT, MIT, Anas e Agenzia del Demanio per recuperare e valorizzare le case cantoniere in disuso. L’obiettivo è trasformarle in ostelli, ristoranti, centri informativi e culturali. Un primo bando del 2016 coinvolgeva 30 immobili, mentre un successivo bando del 2021 ha messo a disposizione 100 case su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, i risultati sono ancora limitati: solo poche case sono state effettivamente ristrutturate e riassegnate e molte sono ancora in attesa di un futuro.
Un patrimonio da riscoprire
Le case cantoniere, con il loro distintivo colore rosso, rappresentano un pezzo importante della storia e dell’identità italiana. Da semplici alloggi per cantonieri a simboli di un’epoca, queste strutture meritano di essere preservate e valorizzate. I progetti di recupero in corso offrono l’opportunità di dare nuova vita a queste “case rosse”, trasformandole in risorse per il turismo e la cultura locali.